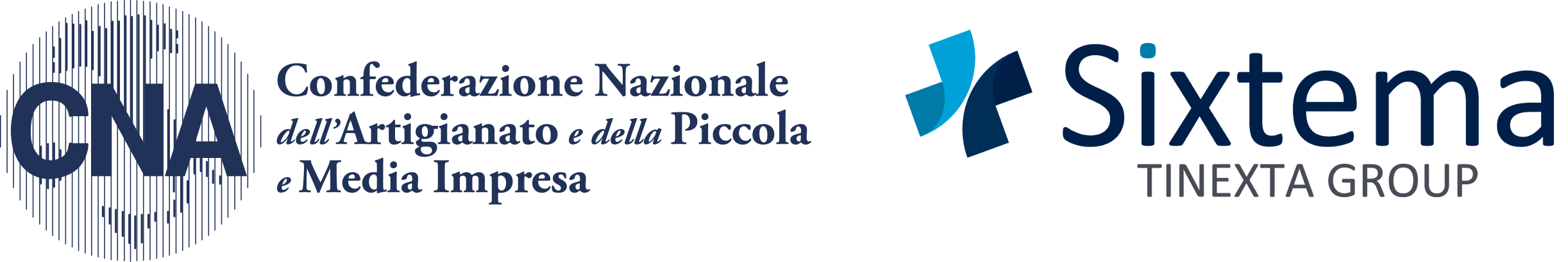Acqua, oltre 600 contributi alla Strategia europea e una richiesta comune: più fondi
 Dialogare con gli allevatori, sfruttare al massimo le tecnologie per il riuso, definire una scala di priorità degli utilizzi e applicare il principio "chi inquina paga": sono le direttrici secondo le quali si muoverà la Strategia per la resilienza idrica che la commissaria UE Jessica Roswall sta preparando. La deadline prevista è la fine di giugno e il 4 marzo si è chiusa la consultazione pubblica. Oltre 600 i pareri arrivati, con un comune denominatore: la richiesta di fondi. Ma questo sembra proprio essere il punto debole del piano.
Dialogare con gli allevatori, sfruttare al massimo le tecnologie per il riuso, definire una scala di priorità degli utilizzi e applicare il principio "chi inquina paga": sono le direttrici secondo le quali si muoverà la Strategia per la resilienza idrica che la commissaria UE Jessica Roswall sta preparando. La deadline prevista è la fine di giugno e il 4 marzo si è chiusa la consultazione pubblica. Oltre 600 i pareri arrivati, con un comune denominatore: la richiesta di fondi. Ma questo sembra proprio essere il punto debole del piano.
La consultazione sulla Strategia europea per la resilienza idrica
Partiamo dalla fine, dai fondi che dovranno essere messi a disposizione: nella sua audizione al Parlamento italiano (link in fondo all'articolo), la commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare, Jessica Roswall, ha citato voci di investimento già esistenti: fondi della Politica di Coesione, PNRR, Politica agricola comune (PAC), e non ha esplicitamente promesso stanziamenti nuovi. Si sta lavorando a «nuove soluzioni per spingere gli investimenti» e a «contatti con la BEI», ha detto. Puntando poi su altre due parole: tecnologie e dialogo. Alla parola "dialogo" bisogna leggere il riferimento a settori particolarmente critici come quello degli allevatori, le cui proteste un anno fa congelarono i piani della von der Leyen.
Sulla scrivania della commissaria ci sono le oltre 600 osservazioni arrivate entro il 4 marzo in risposta alla consultazione pubblica UE sulla Strategia di resilienza idrica. Dovrà tenerne conto per la scrittura del documento, che - secondo quanto ha lei stessa annunciato - dovrà essere pubblicato alla fine del trimestre appena iniziato. A chiedere più fondi, soprattutto per nuovi investimenti nel settore sono stati - come vedremo - numerosi stakeholders non solo italiani e anche - esplicitamente - la viceministra del Mase, Vannia Gava.
La questione acqua in Europa e in Italia: quali criticità
«La fissazione dell'Europa per l'energia ha lasciato la crisi idrica fuori controllo», ha detto un funzionario europeo riportato dal Financial Times nell'intervista alla commissaria, che ha aggiunto: «La scarsità d’acqua è un problema che a livello comunitario non può essere sottovalutato, colpisce ogni anno un quinto del territorio dell’UE e quasi un terzo della sua popolazione. Le aziende lo hanno capito ora perché abbiamo avuto periodi di siccità in Europa. Vediamo anche che le centrali nucleari non funzionano davvero e che il trasporto sui grandi fiumi non funziona».
Per comprendere bene quale sia la posta in gioco inquadreremo il problema a livello globale scendendo poi fino al quadro nazionale: secondo gli ultimi dati diffusi dal Forum Ambrosetti, 1,6 miliardi di persone nel mondo soffrono la scarsità d’acqua economica, 2,2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile e servizi idrici di base, 2 persone su 5 non hanno una struttura per lavarsi le mani con acqua e sapone in casa, 630 milioni di persone utilizzano servizi igienici condivisi con almeno un altro nucleo familiare. Le problematiche relative all'acqua sono responsabili del 10% di aumento della migrazione globale tra il 1970 e il 2000.
La salute media dei corpi idrici superficiali europei è critica, con solo il 37% che raggiunge un buon stato ecologico e solo il 29% che raggiunge un buon stato chimico, e ciò è dovuto soprattutto al mercurio e ad altri inquinanti. Inoltre deve vedersela con la scarsità di acqua il 20% del territorio europeo e il 30% della popolazione. Il continente è sempre più soggetto ad alluvioni e a fenomeni meteorologici estremi, che hanno hanno un costo economico da affrontare. Negli ultimi anni, eventi come la siccità del 2022, poi le recenti alluvioni, sono costati oltre 40 miliardi di euro. Una cifra che potrebbe crescere sei volte entro la fine del secolo. L’Osservatorio europeo sulla siccità nel mese di agosto stimava, a causa della carenza idrica, che il 60% del territorio europeo si trovasse in condizioni critiche.
In Italia, 780 Comuni sono stati interessati da eventi metereologici estremi tra il 2010 e fine ottobre 2022, vale a dire poco meno del 10% del totale, il 74% dei disastri naturali sono legati all’acqua, con una crescita del 50% in 10 anni e una frequenza di 4 volte maggiore rispetto al 1980. Gli impatti diretti, indiretti e indotti del ciclo idrico esteso - che comprende il Servizio Idrico Integrato e i fornitori di input - raggiungono un Valore Aggiunto di 11 miliardi di euro nel 2023, in crescita con un tasso annuo medio anno del +5,5% dal 2015 al 2023. Tale performance è superiore alla media della manifattura, che cresce del 4,1%, e all’aggregato del Paese (+3,2%) nello stesso periodo. In Italia ci sono 1,1 milioni di imprese agricole, 330 mila imprese manifatturiere idrovore, 10 mila imprese del settore energetico e 95700 posti di lavoro legati all'acqua.
La risorsa idrica rinnovabile, cioè quella che si produce naturalmente nel territorio di riferimento esclusivamente dalle precipitazioni, è stimata ridursi del 40% entro il 2100 in Italia, con picchi del 90% al Sud. Invasi, reti, sistemi di depurazione sono i pilastri su cui si fonda la rete idrica del nostro Paese. Ma solo ad esempio per gli invasi, 1,8 miliardi di metri cubi non sono autorizzati per motivi infrastrutturali e ambientali, il 14% dei volumi delle grandi dighe italiane non è sfruttato, il 22% della rete idrica italiana ha più di 50 anni, mentre 1,3 milioni di italiani vivono in Comuni privi del servizio di depurazione.
Acqua, la Strategia europea: orientamento e prime tracce
L'obiettivo principale della Strategia europea per la resilienza idrica è stabilire un percorso verso la sicurezza dell'acqua garantendo la disponibilità di acqua pulita e proteggendo meglio l'UE dai rischi legati alla sua scarsità o scarsa qualità ecologica. Inoltre, si tratta di una componente chiave della competitività dell'UE.
La strategia si concentrerà su tre obiettivi specifici:
- Ripristinare e proteggere il ciclo dell'acqua;
- Garantire acqua e servizi igienico-sanitari puliti e convenienti per tutti;
- Promuovere un'industria idrica competitiva dell'UE come parte di un'economia circolare pulita e basata sull'acqua.
I cinque ambiti di intervento, invece, sono: governance e attuazione; infrastruttura; finanza e investimenti; sicurezza; industria, innovazione e istruzione. Come già fatto per l'energia, anche in questo caso la Commissione UE intende dare priorità al principio 'Prima l'Efficienza Idrica' ('Water Efficiency First, in inglese) per aumentare il riutilizzo e la circolarità dell'acqua attraverso investimenti e innovazioni su larga scala.
«Non stiamo facendo abbastanza per la nostra acqua», ha sottolineato la commissaria Roswall. Intervenendo in Parlamento e al Forum Ambrosetti ha parlato anche delle risorse: «Dobbiamo prendere in considerazione anche fonti di finanziamento private, perché credo fermamente che ciò che è positivo per la natura sia positivo anche per gli affari», ha detto, appellandosi poi alla necessità di tenere aperto il dialogo con tutta la filiera. Alla domanda se i consumatori dovranno pagare bollette dell’acqua più alte, Roswall ha risposto più volte che si tratta di una questione di competenza dei comuni, ma ha aggiunto che «dobbiamo cercare nuovi modi innovativi di finanziare» le condutture e gli impianti di depurazione. Rientrano nel capitolo "esplorazione di nuovi finanziamenti" anche i recenti contatti con la BEI. «Il costo del non fare è superiore», ha detto al Parlamento italiano.
Proprio nell'ottica di chiamare in campo il settore privato insieme a quello publbico e di tenere aperte le «linee di dialogo», come le ha definite, ha avviato una consultazione pubblica chiedendo contributi non solo degli Stati Membri e delle istituzioni europee, ma anche di stakeholder come le autorità locali, il settore privato, le ONG e i cittadini.
Oltre 600 contributi da armonizzare
Questo è il contesto in cui si muove la Strategia europea per la resilienza idrica. La consultazione pubblica ha coinvolto oltre 600 operatori, stakeholders in tutta Europa. Non troppo folta la rappresentanza dei portatori di interesse italiani, nonostante siamo il Paese con perdite idriche molto importanti, più della media europea. Il Belgio è il paese che ha maggiormente partecipato alla consultazione, seguito da Germania, Francia, Spagna e poi Italia. Le associazioni di categoria rappresentano il settore più attivo. Al secondo posto ci sono i singoli cittadini seguiti dalle aziende private e poi dalle Ong.
Per quanto riguarda gli italiani, precisa è la richiesta proveniente da Federlegnoarredo: chiede un'uniformità tra le varie etichette ambientali: "un'etichetta idrica unificata sarà necessaria - scrivono - per poter determinare il reale consumo di acqua nel processo produttivo con una metodologia robusta» e applicabile uniformemente.
Per Cassa depositi e prestiti sono necessari sostanziali investimenti (e coordinati, come precisato da Italgas e dal CNR) per sostenere soprattutto il Sud dell'«Italia che è un hotspot del cambiamento climatico». Inoltre, aggiunge CDP, «per garantire acqua pulita, sicura e accessibile a tutti, i piani di investimento dovrebbero concentrarsi sull'aumento della ridondanza delle fonti d'acqua». Insomma, più fondi ma anche razionalizzazione degli stessi, che è la direttrice lungo la quale si sta muovendo la commissaria Roswall.
Chiedono investimenti certi, programmati nel tempo e coordinati anche le università (esplicito il riferimento in molti interventi, dalla società Suez francese all'istituto tedesco Leibniz ad esempio), associazioni ambientaliste e di categoria e singoli operatori. Molti sono i riferimenti al ciclo dell'acqua e alla necessità del riuso, non solo come target ambientale ma anche come business plan da implementare (in tal senso, il WWF Spagna, il Governo delle Fiandre belga, la Confindustria danese, solo per citarne alcuni).
Il PNRR e la risorsa idrica
Tra gli strumenti di derivazione europea per affrontare la crisi idrica italiana c'è sicuramente il PNRR. Sebbene oggi il 73% degli investimenti dei gestori idrici sia sostenuto dalla tariffa, il PNRR è stato un'iniezione di fondi e investimenti pubblici per l'intera filiera, che "cuba" 8,9 miliardi di fondi europei, così suddivisi:
- 2,5 miliardi di euro alla gestione del rischio alluvione e riduzione del dissesto idrogeologico
- 2 miliardi di euro per infrastrutture idriche primarie
- 2 miliardi di euro per la riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
- 880 milioni per la resilienza dell'agrosistema irriguo
- 600 milioni agli investimenti in fognatura e depurazione
- 500 milioni per un sistema di monitoraggio e previsione dei cambiamenti climatici
- 400 milioni per i fondali marini e il ripristino degli habitat.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha una cabina di regia che si occupa delle infrastrutture idriche: il piano si chiama PNIISSI e a luglio 2024 ha ricevuto richieste dagli operatori per 12 miliardi di euro. Come è noto, la "vita" dei progetti del PNRR arriva fino al 2026, poi sarà tutto da negoziare, e proprio la Corte dei Conti ha mostrato recentemente preoccupazione per la stabilità degli investimenti e la loro effettiva spesa. Il tema è proprio quello di convogliare sulla risorsa idrica investimenti già esistenti, e non di prevederne nuovi, stabili e dedicati.
Su acqua, i dati e l'allarme della Corte dei Conti
Secondo la Corte dei Conti, «il sistema di prelievo e trattamento delle acque in Italia si fonda su una governance multilivello e sul Servizio idrico integrato con alcuni ambiti territoriali gestiti in economia e caratterizzati da una bassa capacità di investimento. A fronte di un fabbisogno stimato di 6 miliardi di euro annui, i giudici contabili rilevano che le entrate non superano i 4 miliardi, con una previsione delle spese correnti peraltro fortemente aleatoria, poiché formata per circa un terzo dal costo dell’energia elettrica. Dei 5,3 miliardi di euro riferiti ai 628 interventi in corso, 3,7 sono ascrivibili al PNRR, soprattutto per investimenti sulla sicurezza dell’approvvigionamento idrico e sulla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione». Cosa accadrà quando i fondi PNRR finiranno? Ci saranno altri finanziamenti publbici? I privati risponderanno alla "chiamata alle armi" della commissaria? Sono queste le sfide alle quali la Strategia europea entro tre mesi dovrà rispondere efficacemente.
Per approfondire: l'audizione della Commissaria Eu Jessika Roswall in Parlamento
La consultazione sulla Strategia di resilienza idrica europea
o