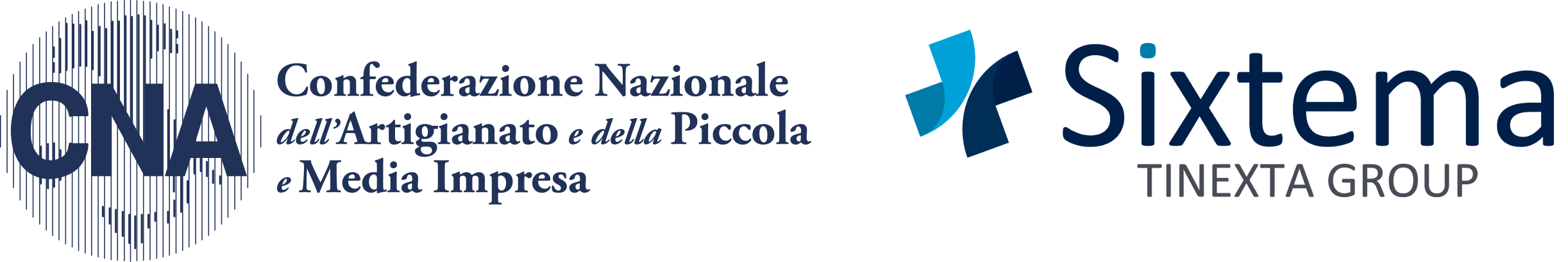DNSH: online le nuove FAQ per gli investimenti PNRR del MASE
 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato le nuove FAQ dedicate al principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Il documento offre chiarimenti e indicazioni operative per supportare i soggetti attuatori nell’applicazione del principio agli interventi PNRR di competenza del MASE.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato le nuove FAQ dedicate al principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Il documento offre chiarimenti e indicazioni operative per supportare i soggetti attuatori nell’applicazione del principio agli interventi PNRR di competenza del MASE.
Il rispetto del principio DNSH negli interventi PNRR: il vademecum del MASE
Le nuove FAQ si inseriscono nel quadro delle attività di accompagnamento realizzate dall’Ufficio Supporto Tecnico della DG COGESPRO dell’Unità di Missione PNRR e hanno l’obiettivo di favorire una corretta e uniforme applicazione del DNSH nell’attuazione degli interventi PNRR del MASE.
Queste sezioni esplicative chiariscono, in particolare, i dubbi più ricorrenti, dalla definizione del principio DNSH ai principali contenuti della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22/2024), dalle modalità di compilazione delle check-list DNSH agli errori da evitare, anche in fase di rendicontazione degli interventi PNRR.
Tra le novità anche un quesito e la sua risposta specifica per l’Investimento M2C2 | 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys), con indicazioni sulle schede DNSH applicabili agli impianti FER collegati agli elettrolizzatori.
FAQ MASE: Cos’è il principio DNSH
La prima parte delle FAQ fornisce informazioni di contesto importanti, partendo dalla definizione del principio stesso e dalla necessità che le amministrazioni titolari (come il MASE) controllino che i soggetti attuatori rispettino il principio.
Anzitutto, il principio DNSH (“Do No Significant Harm”, ovvero “non arrecare un danno significativo” all’ambiente) nasce per coniugare le politiche di sviluppo con la tutela dell’ecosistema, allo scopo di garantire che gli investimenti finanziati con le risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
Introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, noto anche come Regolamento sulla tassonomia dell’UE, il principio DNSH promuove gli investimenti sostenibili valutando se una misura possa o meno arrecare un danno a sei obiettivi, due climatici e quattro ambientali, individuati dal Green Deal:
- Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Adattamento ai cambiamenti climatici;
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- Transizione verso un’economia circolare;
- Prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In tale contesto, ricorda il Ministero, nel processo di attuazione degli interventi PNRR, le amministrazioni titolari devono garantire che i soggetti attuatori, pubblici o privati, rispettino il principio DNSH lungo l’intero ciclo di vita dei progetti, dalla progettazione alla conclusione. Da questa esigenza nasce l’iniziativa del MASE di fornire un supporto ai soggetti attuatori pubblicando FAQ e vademecum dedicati.
Le FAQ DNSH del MASE
Fornite le informazioni di contesto, il MASE passa poi a questioni più specifiche. Tra queste, anzitutto, la verifica della conformità al DNSH. A tal proposito, viene specificato che “i vincoli da rispettare per garantire la conformità di un progetto PNRR al princpio DNSG sono riassunti nella Guida Operativa del MEF di maggio 2024”. La Guida contiene, in particolare:
- le mappature che associano ogni misura PNRR ad una o più schede tecniche applicabili, indicando quali misure forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi climatici o ambientali.
- una serie di schede tecniche, redatte per settore di attività, contenenti i vincoli DNSH applicabili e gli elementi di verifica;
- una serie di check list allegate alla Guida, dove sono riassunti gli elementi di verifica ex ante ed ex post per ciascuna scheda tecnica, da utilizzare in fase di rendicontazione.
Altra questione rilevante affrontata dalle FAQ del MASE è il Regime DNSH. In base al contributo atteso dalla misura PNRR agli obiettivi climatici o amvientali, infatti, gli interventi sono inquadrati in due diversi Regimi DNSH: nel Regime 1, dove rientrano le misure per le quali il PNRR ha previsto un contributo sostanziale ad un determinato obiettivo, si applicano criteri DNSH più stringenti volti a dimostrare un impatto positivo e misurabile dell’attività (ad esempio la riduzione delle emissioni); il Regime 2, invece, di applica a tutte le misure, anche quelle che non contribuiscono direttamente ai sei obiettivi ambientali/climatici, che devono però comunque dimostrare di non arrecare un danno significativo.
Le FAQ del Ministero spiegano poi cosa sono le schede tecniche DNSH contenute nella Guida Operativa del MEF. Tali schede sono fondamentali perché forniscono alle amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori le informazioni operative e normative necessarie per rispettare i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH. Ogni scheda è dedicata ad un settore di intervento e contiene una sintesi organizzata delle verifiche da effettuare in fase ex-ante (progettazione) e in fase ex-post (conclusione), suddivise per obiettivo, con la specifica evidenziazione di quali vincoli si applichino nel caso in cui alla misura sia assegnato un Regime 1.
Legate alle schede tecniche, sottolinea il MASE, sono le check-list allegate alla Guida Operativa, da utilizzare in fase di rendicontazione. Le check-list, in sostanza, riassumono le verifiche previste dalle schede tecniche corrispondenti al fine di garantire la conformità degli interventi al DNSH. Per compilare una check-list, i soggetti attuatori sono tenuti ad indicare il tempo di svolgimento delle verifiche, il numero delle verifiche, gli “elementi di controllo” ovvero le verifiche previste dalle schede tecniche corrispondenti, nonché l’esito di tali verifiche.
A tal proposito, gli errori più comuni da evitare secondo il MASE in fase di compilazione delle checklist sono:
- risposte generiche e non motivate, che non chiariscono come sono stati rispettati i criteri;
- adempimento formale o tardivo, ovvero non considerare le corrette schede DNSH applicabili fin dalla progettazione dell’intervento oppure compilarle solo nella fase di esecuzione, con il rischio di trovarsi in fase ex post a dover ricostruire la documentazione necessaria a garantire la sostenibilità ambientale delle attività;
- mancanza di documentazione a supporto che comprova la conformità (relazioni tecniche, autorizzazioni, certificazioni);
- non dare conto dell’analisi di adattabilità: è l’elemento più innovativo del principio DNSH e va sempre considerato, al fine di valutare la vulnerabilità e l’esposizione dell’opera ai rischi climatici;
- non aggiornare la check-list dopo modifiche progettuali significative nel progetto, lasciando quindi delle incongruenze tra la fase progettuale e la realizzazione effettiva.
Relativamente alla dimostrazione della conformità al principio DNSH in fase di rendicontazione, il Ministero sottolinea come sia necessario trasmettere le check-list attraverso il sistema Regis. Per le specifiche misure di competenza del MASE, in sede di presentazione del primo rendiconto di progetto, il soggetto attuatore deve trasmettere la check list compilata con riferimento alla sola sezione ex-ante. In fase di rendicontazione finale, invece, la stessa check list, completa anche delle verifiche richieste nella sezione ex-post, deve essere allegata al rendiconto insieme ad una cartella contenente tutta la documentazione a comprova del rispetto del principio DNSH.
Tale processo di rendicontazione del rispetto del principio DNSH è importante anche per la rendicontazione delle spese, fase in cui il soggetto attuatore deve giustificare gli importi sostenuti e dimostrare il rispetto del principio nell’effettuazione delle spese progettuali. E’ quindi fondamentale che produca e conservi adeguata documentazione probatoria, anche in vista di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Questo processo è essenziale per garantire la corretta erogazione dei fondi europei, poiché il mancato rispetto del principio può comportare la perdita del contributo finanziario o la richiesta di restituzione delle somme già ricevute.
Tra i contenuti delle FAQ, anche le Appendici 1 e 2 della Guida Operativa DNSH del MEF, introdotte con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di maggiore chiarezza operativa per enti pubblici, progettisti e stazioni appaltanti, facilitando l’integrazione dei requisiti ambientali e climatici nei progetti e nelle procedure di appalto, in linea con gli obblighi europei e nazionali.
In particolare, l’Appendice 1 fornisce una metodologia basata sul Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139) per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici. In pratica, l’Appendice introduce criteri pratici per valutare se un intervento si adatta ai cambiamenti climatici e non provoca danni significativi all’ambiente, assicurando il rispetto del principio DNSH.
L’Appendice 2, invece, individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM), previsti dall’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e li mette in relazione con le schede DNSH. I CAM rappresentano specifiche misure finalizzate ad integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle varie categorie di appalti della PA e si inseriscono tra gli strumenti previsti per i cosiddetti “Appalti Pubblici Verdi” (Green Public procurement). I CAM non possono sostituire le prescrizioni derivanti dall’applicazione del principio DNSH, che garantiscono un livello di tute superiore delle matrici ambientali, ma sono comunque utili per assicurare il rispetto del DNSH nel caso del Regime 2 (quello con criteri meno stringenti).
Nelle FAQ, infine, il MASE si concentra anche sull’analisi dell’adattabilità ai rischi climatici. Come anticipato, uno dei sei obiettivi ambientali del Green Deal è l’Adattamento ai cambiamenti climatici, che risponde alla necessità di assicurare il maggior grado possibile di resilienza dell’opera PNRR ai rischi climatici fisici (come siccità, alluvioni, terremoti). Come specificato nella Guida Operativa MEF, “il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato: i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto)”. Alla luce di ciò, i soggetti attuatori devono quindi verificare, in fase progettuale, se l’opera sia esposta a rischi climatici fisici ed eventualmente individuare le soluzioni di adattamento più opportune all’interno del report o relazione di adattabilità, che deve essere redatto anche se l’opera non risulta esposta a rischi significativi.
Consulta le FAQ MASE per il rispetto del principio DNSH
Il principio DNSH nell’Investimento M2C2 I3.1 per le Hydrogen Valleys
In relazione all’Investimento M2C2 | 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” (Hydrogen Valleys), le FAQ del Ministero chiariscono quali schede della Guida Operativa DNSH di maggio 2024 si applicano agli interventi finanziati.
Per l’Investimento PNRR sono previste, in particolare, tre schede tecniche:
- quella dedicata alla produzione e allo stoccaggio di idrogeno (scheda n. 15);
- quella per eventuali lavori di ristrutturazione di edifici (scheda n. 2);
- la scheda per attività edilizie generiche non legate direttamente alla costruzione di edifici (scheda n. 5).
Tuttavia, come precisato dalla Guida Operativa, il MASE ricorda che l’associazione delle schede è puramente indicativa e che spetta, in ultima analisi, al soggetto attuatore verificare, per ciascun progetto, quali schede si applichino realmente e se sia necessario includerne altre.
Nel caso specifico dei progetti per le Hydrogen Valleys che finanziano impianti con elettrolizzatori e fonti rinnovabili asservite, le FAQ evidenziano che devono essere sempre considerate le schede n. 15 e quelle relative agli impianti a fonti rinnovabili collegati (ad esempio la scheda n. 12 per il fotovoltaico o la n. 13 per l’eolico).
Per approfondire: MASE: fondi alle hydrogen valley in aree industriali dismesse