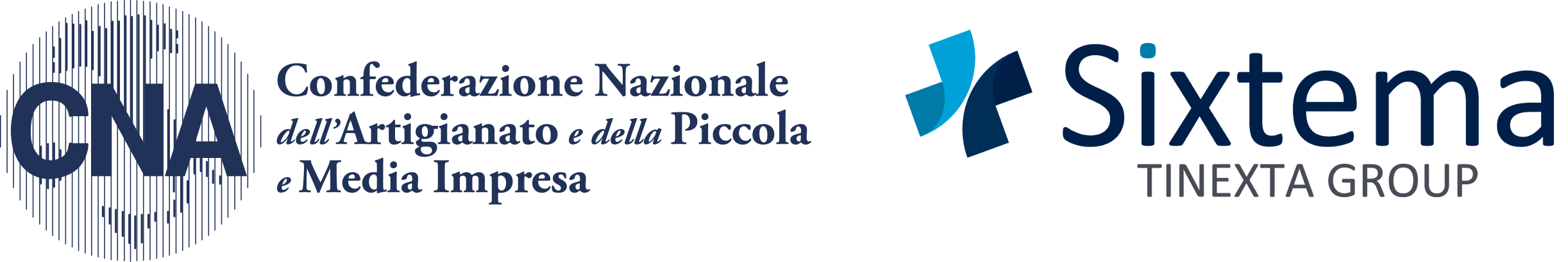Make Europe Great Again: Aiuti di Stato più semplici ed efficaci per un’Europa più forte
 La regolamentazione europea sugli aiuti di Stato impedisce che gli Stati membri concedano dei vantaggi economici e finanziari alle proprie imprese in misura contraria all’interesse comune europeo, interesse comune che solo le Istituzioni Europee possono stabilire.
La regolamentazione europea sugli aiuti di Stato impedisce che gli Stati membri concedano dei vantaggi economici e finanziari alle proprie imprese in misura contraria all’interesse comune europeo, interesse comune che solo le Istituzioni Europee possono stabilire.
Garanzie e aiuti di stato: la Commissione si prepara ad una revisione
I poteri delle Istituzioni Europee in materia risalgono ai tempi della creazione del mercato comune europeo e sono una tutela per i consumatori e per le imprese stesse, a partire da quelle che operano negli Stati membri più deboli finanziariamente.
La regolamentazione è però diventata sempre più articolata e ingessata, non adatta ai cambi di scenario sempre più rapidi e imprevedibili prodotti dalla globalizzazione dell’economia, dall’interventismo della Cina e accelerati da ultimo dal neo-protezionismo degli USA di Trump 2°.
Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono ancora validissimi, ma è ormai urgente un aggiornamento se non una riarticolazione della regolamentazione, che si proponga di fondare su una rinvigorita centralità del concetto di comune interesse europeo.
Spetta alla Commissione trovare un nuovo equilibrio tra potenziale distorsione della concorrenza e perseguimento del comune interesse europeo, adeguato al mutato scenario geopolitico.
Occorre anche tenere conto che gli aiuti che gli Stati membri possono concedere senza una apposita autorizzazione della Commissione UE (i cd. aiuti esenti) sono oggi 62 - erano 2 nel 2001 e 26 nel 2008 - e le discipline sugli aiuti di Stato soggetti ad una autorizzazione semplificata (i cd. quadri temporanei), fino al 2020 eccezionali, sono ora sempre più frequenti.
Nella ricerca di tale aggiornato equilibrio la Commissione dovrebbe pertanto considerare anche che il meglio è spesso nemico del bene e che la semplicità di applicazione delle regole le rende più efficaci e più condivisibili.
Blending finance
Le tipologie di aiuti esenti aggiunte più di recente sono utilizzate molto di rado e tra queste una decina riguardano il finanziamento di progetti ritenuti validi nell’ambito di programmi europei (ricerca, ambiente, finanziamento delle imprese innovative, inclusione, salute, difesa, altro), differenti da quelli la cui gestione è delegata agli Stati membri, ma non finanziati direttamente dal bilancio europeo, spesso per insufficienza di risorse.
A fronte della scarsa disponibilità degli Stati membri di aumentare i propri contributi “generici” al bilancio europeo, appare ottima l’idea di irrobustire i programmi di interesse comune attraendo le risorse degli Stati membri sui singoli progetti ritenuti validi, nella misura in cui ciascuno veda coinvolte le proprie imprese.
Questa forma di cooperazione finanziaria ad assetto variabile meriterebbe di essere trattata sotto il profilo degli aiuti di Stato in modo strutturale, partendo dalla considerazione che se la selezione dei singoli progetti avviene da parte delle Istituzioni Europee, che stabiliscono anche l’ammontare dell’aiuto concesso e le condizioni, già si impedisce alla radice che gli Stati membri concedano dei vantaggi economici e finanziari alle proprie imprese in misura contraria all’interesse comune europeo.
Si ritiene che questo risultato potrebbe essere raggiunto con un ricorso più coraggioso da parte della Commissione agli “aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo” (art. 107 (3) (b) del TFUE), maggiormente utilizzati di recente, ma sempre in modo molto circoscritto.
Peraltro, lo scarso ricorso a tali aiuti esenti è anche dovuto al fatto che gran parte dei progetti ritenuti validi dalle Istituzioni Europee sono proposti da imprese appartenenti a più Stati membri, per cui difficilmente i singoli Stati membri sono interessati a finanziarli per intero.
Il finanziamento strutturato e non solo episodico di tali progetti deve necessariamente avvenire in modo coordinato e solo le Istituzioni Europee possono fornire questo coordinamento super partes.
Chi scrive, ritiene che i vantaggi economici ritenuti riconoscibili direttamente dalle Istituzioni Europee, o comunque sotto il loro forte indirizzo e controllo, potrebbero non essere neppure aiuti di Stato in quanto l’esistenza di una selezione da parte di uno Stato membro è un elemento indispensabile affinché un aiuto sia di Stato (capitolo 5 della Comunicazione sulla Nozione di Aiuto di Stato, NOA).
Mancano orientamenti degli Organi Giurisprudenziali Europei su tali forme di blending financing bottom-up, con deleghe degli Stati membri alle Istituzioni Europee.
D’altra parte, si tratta di formule introdotte solo di recente ad esempio con i comparti nazionali di Invest EU. Non sembra che i mandati conferiti dalla Banca Europea degli Investimenti agli implementing partners, anche quando si tratta di National or Regional Promotional Bank of Institution (NRPBIs) di proprietà degli Stati membri, siano comparabili con la “selettività amministrativa” che normalmente caratterizza la gestione di risorse proprie da parte degli Stati membri. Alle NRPBIs, in un quadro di politiche di investimento predefinite dalle Istituzioni Europee, è richiesto piuttosto di eseguire una selezione su ”l’ultimo miglio” sostanzialmente finanziaria, paragonabile a quella che eserciterebbe un intermediario finanziario commerciale (situazione ibrida rispetto quelle esaminate al p. 60, par. 3.2.2. “Influenza dominante sulle risorse” della NOA).
L’obiettivo di incentivare una maggiore cooperazione finanziaria a sostegno delle politiche delineate di interesse comune a livello europeo, capace di attrarre ulteriori risorse dei singoli Stati membri anche ad assetto variabile, sembra meritare comunque una riflessione approfondita sulla nozione di aiuto di stato in tali circostanze.
Tale obiettivo potrebbe meritare anche altre forme di incentivo, ad esempio in termini di minore cofinanziamento nazionale dei fondi europei la cui gestione è delegata agli Stati membri, se non addirittura abbuoni nell’ambito delle regole sui conti pubblici nazionali.
Il sostegno all’offerta alle imprese di servizi per la ricerca e l’innovazione
Esiste ampio consenso sul fatto che la competizione a lungo termine tra le economie continentali dipende dalla loro capacità di sviluppare e portare sul mercato innovazioni tecnologiche. Gli USA e la Cina risultano molto più efficaci ed efficienti rispetto all’Europa nel trasformare in valore economico la capacità di fare ricerca.
La regolamentazione sugli aiuti di Stato all’offerta di servizi R&S per le imprese, incluso l’accesso alle infrastrutture, è complicata. Essa si basa sulla distinzione tra la ricerca destinata ad essere messa a disposizione dell’intera collettività degli studiosi e degli studenti (gratuitamente?), tramite le pubblicazioni scientifiche e la didattica, attività liberamente finanziabile dagli Stati membri, e la ricerca destinata ad essere utilizzata dalle imprese (a pagamento?), attività economica e di mercato, e pertanto soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato.
Tale distinzione si è resa necessaria a causa dei differenti regimi giuridici degli Stati membri e dalla lunga storia che ha plasmato, in mancanza di una regolamentazione comune, le diverse istituzioni che si occupano della ricerca (es. proprietà pubblica o privata delle Università).
È evidente quanto questa distinzione sia complicata da applicare nella pratica, persino nella didattica. Chi potrebbe oggi dire che non esiste un mercato dei master per talune discipline?
L’attuale regolamentazione è in particolare estremamente complicata nel caso degli investimenti destinati a offrire servizi di ricerca, in quanto il finanziamento pubblico concedibile è funzione dell’attività che sarà svolta in futuro (100% per l’attività non economica, 50% per l’attività di ricerca industriale, e 35% per l’attività di sviluppo sperimentale). Tale regolamentazione può addirittura scoraggiare le Università e i Centri di Ricerca dal fornire servizi di ricerca alle imprese, per il rischio di perdere l’accesso incondizionato ai finanziamenti pubblici o dovere restituire quelli già ottenuti.
Sembra indiscutibile che il diffondersi in Europa di soggetti che svolgono ricerca contemperando entrambe le finalità sia di interesse comune europeo.
L’ampia diffusione di “Open Innovation Undertakings” sembra centrale per perseguire l’interesse comune europeo, considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie è di per sé una delle attività economiche a maggiore valore aggiunto nelle catene del valore globale. Favorire il trasferimento tecnologico alle imprese di più piccola dimensione è peraltro funzionale al modello europeo di democrazia economica, con molte imprese di piccola e media dimensione (PMI); in mancanza l’innovazione tecnologica tende a concentrarsi nelle imprese leader di mercato, che hanno i mezzi finanziari per svilupparla o acquisirla.
Nell’attuale articolata regolamentazione - rivolta sia a “entità legali” come gli Organismi di Ricerca e di Diffusione della Conoscenza e i Poli di Innovazione, che a “capacità” come le Infrastrutture di Ricerca e quelle di Prova e Sperimentazione - si intravede tuttavia un percorso per delineare una disciplina per individuare e quindi favorire lo sviluppo di “Open Innovation Undertakings”.
Già oggi la regolamentazione prevede che tali variegate “entità legali” e “capacità” devono tutte offrire i loro servizi R&S e i risultati delle loro attività in modo aperto a tutte le imprese, in presenza di una domanda effettivamente plurale. Tale modello è peraltro quello della Fraunhofer tedesca (di proprietà pubblica), il modello di maggiore successo di offerta di servizi e infrastrutture per la R&S delle imprese effettivamente sperimentato in Europa.
Si ritiene opportuno prevedere un’unica tipologia di entità legale, la “Open Innovation Undertakings” appunto, le cui attività potrebbero estendersi anche alla accelerazione e ricerca di investimenti equity (attività R&S&I). Tali entità legali andrebbero sostenute con aiuti di Stato particolarmente generosi per gli investimenti (50%), ma anche per i costi di funzionamento di cui ha fruito la Fraunhofer per lungo tempo. Questi ultimi devono essere strutturali, perché le difficoltà di coordinamento nelle attività R&S&I effettivamente aperte a una pluralità di utenti non sono presenti solo in una fase di avviamento, ed eventualmente proporzionati ai ricavi di mercato (o a determinati ricavi, ad esempio il 50% delle vendite a PMI) e quindi ad un indicatore certo e di mercato del gradimento sull’operato della singola “Open Innovation Undertakings”.
Ovviamente bisogna evitare che tali “Open Innovation Undertaking” siano in verità dedicate a servire una o poche imprese, specie di grandi dimensioni, e già oggi ci sono delle previsioni in tal senso: le imprese socie o finanziatrici non possono avere un accesso privilegiato ai risultati della ricerca o tale privilegio deve essere riservato alle imprese che hanno impiegato i propri capitali, momentaneo e proporzionato all’impegno finanziario.
Se tali previsioni sono ritenute insufficienti possono esserne adottate di più stringenti, anche una vigilanza europea rafforzata, se non oggetto di una 28° giurisdizione, peraltro già delineata per gli European Research Infrastructure Consortium (ERIC).
Sviluppare un’efficace offerta europea di servizi e infrastrutture per l’innovazione tecnologica delle imprese, specie delle PMI, non è meno fondamentale che promuovere un efficiente offerta di capitale di rischio per portare tali innovazioni tecnologiche velocemente al mercato, obiettivo per il quale è stata già proposta appunto la 28° giurisdizione. A ben vedere si tratta di due pilastri dello stesso ponte, ciascuno altrettanto necessario per rendere più robusto e veloce il percorso delle tecnologie dall’accademia al mercato.
Aiuti alle infrastrutture e non aiuti
Un’altra famiglia di aiuti esenti proliferata in tempi più recenti è quella degli aiuti di Stato alle infrastrutture (aeroporti, porti, infrastrutture energetiche, di trasmissione dati, sportive, culturali, di interesse locale, altro). La soluzione individuata è, in genere, che il finanziamento pubblico a tali investimenti debba essere limitato al cd. deficit di finanziamento (cd. funding gap), vale a dire al netto dei futuri flussi di cassa attualizzati.
Tale proliferazione è sorta a seguito di alcune pronunce degli Organi Giurisdizionali dell’Unione riguardanti la realizzazione di infrastrutture aeroportuali appositamente concepite per attrarre delle imprese operanti nel settore della logistica.
A ben vedere sembra occasionale il fatto che tali pronunce riguardino infrastrutture aeroportuali da realizzare appositamente, perché il trasferimento di un vantaggio economico e finanziario all’operatore economico si sarebbe verificato anche nel caso di affidamento della gestione di infrastrutture pubbliche già esistenti, con le medesime conseguenti problematiche relative agli aiuti di Stato.
Il problema degli aiuti di Stato derivanti dalla messa a disposizione degli operatori economici di beni realizzati con risorse pubbliche, o meglio di beni pubblici (es. demanio marittimo), appare un problema di natura generale e che andrebbe affrontato come tale. Appare necessario anzitutto aggiornare una vecchia comunicazione del 2001, riguardante la messa a disposizione degli immobili pubblici, ampliandone la portata, ad esempio comprendendo il tema ormai incombente della messa a disposizione dei dati pubblici (es. sanitari).
Tale disciplina deve essere ben integrata con quella riguardante i contratti pubblici, e quindi la realizzazione delle infrastrutture di proprietà pubblica, altro ramo della disciplina europea della concorrenza. Questo altro ramo sostiene che in presenza di una procedura competitiva rispettosa del diritto europeo, il corrispettivo di aggiudicazione è il prezzo di mercato. Quando un operatore economico realizza lavori o vende beni o servizi a prezzi di mercato non ottiene alcun vantaggio economico e finanziario avente natura di aiuto di Stato.
Il metodo del cd. “funding gap” andrebbe quindi applicato alle sole infrastrutture di proprietà privata, dove le regole sui contratti pubblici o le regole non si applicano.
In ogni caso servirebbe almeno una definizione di infrastruttura, che dipende dall’esistenza di monopoli o situazioni di privilegio sul mercato (ferrovie, autostrade, sistema idrico, trattamento dei rifiuti, trasmissione distribuzione di energia e dati, altro), ambiti in cui esistono delle modalità consolidate per rispettare il diritto della concorrenza, come l’apertura dei mercati a valle, l’attribuzione di finanziamenti e diritti mediante gare o aste, etc.
Semmai si può sentire l’esigenza di armonizzare e sintetizzare tale modalità in un corpus più organico capace di fare emergere i principi a cui ci si ispira.
Gli ambiti in cui la disciplina sugli aiuti di Stato sarebbe opportuno fosse più chiara riguardano piuttosto le infrastrutture locali e più in generale la predicibilità della esistenza di una potenziale incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, presupposto necessario affinché ci sia un aiuto di Stato.
Le aspettative sono fondamentali per l’economia, e fornire elementi affinché le imprese formulino previsioni attendibili è la politica per la crescita meno costosa che ci sia. Appare necessario, pertanto, che su questi argomenti siano fornite delle linee guida pratiche (come, ad esempio, esistono per gli impianti di risalita di interesse locale), se del caso coinvolgendo preventivamente anche gli Organi Giurisdizionali dell’Unione, visto che hanno l’ultima parola sulla materia. Non si possono attendere dieci anni per sapere con certezza che la gestione comunale di un piccolo porto non è un aiuto di Stato.
Conviene probabilmente ritenere sempre di interesse comune europeo il finanziamento pubblico del patrimonio culturale, anche se la gestione di grandi musei è forse ormai un business (come, d’altra parte, forse è ormai un business la gestione dei master universitari).
Conviene probabilmente anche ritenere sempre di carattere locale le attività economiche svolte in edifici prevalentemente residenziali nel caso di finanziamenti pubblici per l’efficienza energetica degli edifici. Tale previsione, con opportune salvaguardie, era stata inserita in una bozza di revisione degli aiuti esenti per la tutela dell’ambiente, ma è stata poi cancellata nella versione finale.
Anche se una porzione dell’edificio è usata da banche o supermercati, che operano su mercati globali, il beneficio derivante dal finanziamento pubblico rimane un beneficio locale, che non può essere trasferito altrove dall’impresa beneficiaria, così come quello che otterrebbe dalla apertura di una nuova stazione della metropolitana nelle vicinanze. Per contro si deve tenere conto che la ristrutturazione di interi edifici è unitaria e l’immane sforzo di rinnovare il patrimonio immobiliare europeo per renderci autonomi dai combustibili fossili (e dagli Stati che li estraggono) non può essere bloccato dalla presenza nell’edificio di un laboratorio di ortodonzia.
Anche i finanziamenti pubblici all’attività di formazione svolta dalle imprese a favore dei propri lavoratori non si ritiene debbano essere considerati un aiuto di Stato. I lavoratori formati sono infatti liberi di cambiare datore di lavoro (anche di altri Stati Membri) senza alcuna compensazione per l’impresa di origine che ha pagato la loro formazione (con l’eccezione dei giocatori di calcio e forse altre limitate categorie di lavoratori).
Se il finanziamento pubblico non comporta un vantaggio economico per l’impresa (un incremento del suo patrimonio), manca un elemento fondamentale della nozione di aiuto di Stato.
Probabilmente è nel comune interesse Europeo lasciare che gli Stati membri competano tra di loro nel formare lavoratori più competenti, anche se qualche modesto vantaggio economico rimanesse alle imprese, e lasciare le istituzioni europee libere di dedicare le loro energie a questioni di maggiore importanza.
Strumenti finanziari e PMI
Merita un cenno specifico l’esigenza di adeguare la regolamentazione sugli aiuti di Stato, tradizionalmente concepita per i contributi a fondo perduto, quando si applica a interventi pubblici attuati mediante strumenti e prodotti finanziari. Interventi ritenuti fondamentali per mobilitare il credito e i capitali privati nel sostenere maggiori investimenti ritenuti di comune interesse europeo.
È necessario tenere conto che la funzione economica del credito e degli investimenti equity è infatti quella di fornire in modo anticipato la copertura finanziaria a investimenti, ragionevolmente redditizi nel futuro.
La regolamentazione sugli aiuti di Stato è invece concepita sostanzialmente per rimborsare spese già sostenute.
È il carattere profondamente probabilistico degli strumenti finanziari che rende possibile la loro funzione economica e sociale di convogliare il risparmio a favore dell’economia reale, utilizzando ricchezza di oggi per crearne in futuro. È infatti la gestione delle probabilità che consente di rendere mediamente redditizio un portafogli di prodotti finanziari, anche se il singolo prestito ha comunque un rischio di non essere integralmente restituito e non tutti gli investimenti equity generano le plusvalenze attese. La regolamentazione sugli aiuti di Stato raramente si riferisce a investimenti e progetti in termini di portafoglio e di gestione probabilistica dei rischi.
L’Europa non può competere con la Cina e gli Stati Uniti con gli aiuti de minimis. Gli aiuti esenti devono essere più ampiamente disponibili quando implementati attraverso strumenti finanziari, in particolare azionari, che consentano modalità più avanzate e flessibili di condivisione dei rischi e dei profitti con il capitale privato.
La necessità di un aggiornamento della regolamentazione con riferimento agli strumenti finanziari è particolarmente evidente nel caso del divieto di aiuti di Stato alle imprese prive di una prospettiva di sostenibilità sul mercato, il cui sostegno impedisce l’affermarsi di imprese più meritevoli.
Il solo fatto che dei soggetti privati, peraltro esperti (banche, investitori professionali), decidono di finanziare tali imprese mettendo a rischio nuove proprie risorse finanziarie, appare una condizione sufficiente per garantire che tali imprese hanno una prospettiva di sostenibilità sul mercato. Garanzie che si ritengono molto migliori di quelle offerte da una definizione di impresa in difficoltà di natura formale, peraltro inevitabilmente basata sui dati storici piuttosto che sulle prospettive.
Preme infine ricordare la notevole complessità della definizione di PMI, la cui applicazione richiede un notevole impegno sia da parte delle autorità pubbliche che da parte delle imprese beneficiarie. Tale impegno è in gran parte dovuto alla necessità di considerare relazioni rilevanti tra imprese diverse dai rapporti di controllo che determinano i gruppi societari, gli unici considerarti per gli aiuti di modesto importo (cd. De Minimis) e dalla normativa europea sui bilanci consolidati delle PMI (ivi diversamente definite).
E’ quest’ultimo un aspetto minore tra quelli qui trattati, ma se questo paper contribuirà almeno a indurre la Commissione ad utilizzare una definizione semplificata di PMI per la concessione degli aiuti esenti fino ad un certo importo (ad esempio, fino a 10 volte la soglia del De Minimis), l’Europa forse non tornerà grande nuovamente, ma l’autore sarà comunque contento di avere reso le PMI europee … un po’ meno piccole.
Conclusioni
Il potere di regolamentare gli aiuti di Stato è il massimo potere che la Commissione ha sugli Stati membri, di gran lunga superiore a quello derivante dal magro bilancio europeo.
La politica e l’economia devono tornare al centro della gestione della regolamentazione degli aiuti di Stato, come L. Evans e H. Nyssens sostenevano nel lontano 2007, senza essere purtroppo ascoltati (“Economics in State Aid: Soon as Routine as Dentistry”).
Per un’Europa più vicina ai cittadini e alle imprese, sarebbe auspicabile che la regolamentazione degli aiuti di Stato fosse oggetto di discussioni informate tra economisti e non solo tra giuristi, e fosse comunicata il più ampiamente possibile, a partire dalla generazione Erasmus.
C’è stato un tempo in cui l’Europa è riuscita a creare Airbus per contrastare il predominio degli Stati Uniti nel mercato degli aerei passeggeri. Un tempo in cui era possibile distinguere tra mercati in cui era importante proteggere la concorrenza interna e mercati in cui si rischiava di non avere più nulla da proteggere.
Quei tempi devono tornare, anzi la capacità di fare queste distinzioni deve farsi più rapida (come ci ha insegnato Obama con la crisi automobilistica americana del 2009) e riguardano innanzitutto gli aiuti di Stato attuati attraverso strumenti finanziari, per coinvolgere i capitali privati nel realizzare la massa di investimenti necessaria a rendere nuovamente competitiva l’economia europea.
o